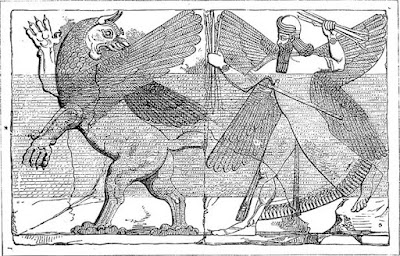La civiltà mesopotamica possedeva infatti una profonda conoscenza del tempo e degli astri, della matematica e della geometria, della medicina e dell’idrodinamica, e altresì nozioni precise della topografia del mondo allora conosciuto (ideologicamente rielaborato a concepire Babilonia come il centro dell’intero universo). I suoi sofisticatissimi miti e i riti a essi connessi, che tanta influenza ebbero anche sul pensiero giudaico della cattività e attraverso di questo sulla cultura cristiana e in ultima analisi occidentale, avevano raggiunto una spettacolarità e ricchezza di significati straordinarie: gli scribi, i veri detentori di questa tradizione, erano capaci di sottigliezze politiche degne della cultura umanistico-rinascimentale italiana. Tutto questo affascinò Ciro assai più del palazzo reale o della ‹ziqqurat› descritta da Erodoto. Non è certo un caso se il primo atto di Ciro, non appena il suo esercito riuscì a entrare in città, fu quello di porre una guardia di armati attorno al tempio Esagila (il cui nome, sumerico, significa ‘Il tempio che solleva al cielo la testa’), in modo che non fosse toccato dal saccheggio. Questo edificio sacro era dedicato al dio principale di Babilonia, Marduk, e aveva rappresentato il fulcro della cultura mesopotamica per duemilacinquecento anni.
La città era dunque stata fondata dai Sumeri, e in lingua sumera era chiamata "KA.DINGIR.RA", la cui traduzione in accadico è ‹Bab-Ilu›, «la Porta di Dio» (si veda anche wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Babilonia). D’Agostino prosegue:
Ciro e i Persiani, insomma, subirono dalla Babilonia conquistata lo stesso fascino che i Romani avvertiranno in seguito nei confronti della Grecia. E lungi dal distruggere quella città, che già il profeta Isaia (13,19), pur maledicendola per la sua immoralità, era stato costretto a definire «il più bello tra i regni, la glorificazione della maestà dei Caldei», Ciro ne fece uno dei gangli economici e culturali del suo impero, permettendo all’accademia annessa al tempio di Marduk, fulcro della tradizione semitica meridionale, di continuare a esistere e prosperare.
Veniamo così a sapere che allorché Ciro conquista Babilonia, nel 539 a.e.v., vi trova un’accademia già funzionate, quindi fondata anni – se non decenni – prima; cosa dobbiamo pensare allora della storiella della fondazione dell’Accademia da parte di Platone nel 367 a.e.v., che è riportata anche da wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Platone#La_fondazione_dell'Accademia) con le parole seguenti:
Nel 387 a.C. Platone è ad Atene; acquistato un parco dedicato ad Academo, vi fonda una scuola che intitola Accademia in onore dell’eroe e la consacra ad Apollo e alle Muse.
È possibile che D’Agostino usi arbitrariamente e metaforicamente il termine “accademia” per una realtà che precedeva quella platonica di oltre centocinquant’anni, a circa 3000 km di distanza da Atene? Oppure il nome “accademia” ha tutt’altra origine, e la storiella di Academo ha il solo scopo di occultare la sua provenienza mesopotamica?
Sulle straordinarie gesta dell’eroe Academo, si veda la pagina dedicatagli da wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Academo).
Il sommario del saggio di D’Agostino è consultabile qui.
_____
¯¯¯¯¯